Due sono gli concetti su cui vi indurrò a riflettere brevemente per dovere di sintesi.
Da una parte la concezione di Spazio pubblico e dall’altra la concezione di Piazza, ambedue gli aspetti ovviamente calati nella tematica urbana che dialoga indissolubilmente con la problematica della antropizzazione del paesaggio e con l’aspetto socio-antropologico dell’agire umano in tali contesti.
Percorro questo impervio sentiero per dibattere con voi del processo legato alla responsabilità di dover tramutare un vezzo di matita in un segno concreto sul territorio.
Il progettista ha il carico di un Edipo che spesso regna dal talamo della madre. Per dirla parafrasando Jung: cosa vale comprendere l’essenza stessa dell’uomo se manca la responsabilità della scelta personale percepibile nel segno a partire dal cogliersi nella capacità simbolica e distinguendo ciò che essa significa per ogni individuo?
Se ogni forma sociale è anche una forma spaziale (Ledrut 1984), le forme sociali sono spaziali e temporali. Nel cercare di spiegare le forme sociali si incontra, dunque, immediatamente il problema fondamentale delle relazioni tra forma e senso: la forma riceve senso o dà senso? Non si può osservare la logica della forma senza comprendere che materia e forma sono reciprocamente legate, assumono significato l’una nell’altra.
Luogo che in assoluto pertanto riveste una qualità simbolica, funzionale, relazionale, di singolarità nell’alterità, mercantile, contrattuale e tanto altro ancora è indubbiamente la Piazza. Essa ha dunque la capacità di tramutare sistematicamente la pluralità dei luoghi in un unico spazio. Tutto ciò per cercare di decostruire in realtà l’iter progettuale che ha portato alla realizzazione della cosiddetta piazza ricavata da uno spazio antistante la chiesa parrocchiale di Aquino.
Ogni cittadino che vive una piazza ha da sempre avuto la possibilità di sperimentare la propria fisicità pervadendo, attraversando e spostandosi in uno spazio all’interno del quale “agisce”. Le piazze parlano dell’uomo e all’uomo, in quanto moltitudine del suo essere intersoggettivo, del muoversi nella dimensione pubblica e dei vantaggi o svantaggi che ciò comporta. Il muoversi verso l’altro, legato al processo fisico dell’agire, dove per “agire” (ago – da cui agorà) è il momento fruttuoso della vita all’aperto.
Potrei forse pensare che in questa particolare formulazione progettuale si possa ravvisare il simbolo di una nuova socialità, articolata in una partizione multifunzionale che era prodromica del più contemporaneo vissuto antropologico. Avrei forse finito col dire che i luoghi del collettivo non esistono più, per via del generalizzarsi della precarietà, che rende i confini tra lavoro e vita quotidiana molto sfumati e singolarizza le esperienze, le rende feste occasionali.
Nell’epoca postmoderna tutto è definito liquido e fluido, pure il pensiero, e perciò: viva i non- luoghi (Augé 1992). Siamo ancora in una fase di controcultura, di messa a morte della piazza – come dell’arte – e in questa fase non c’è posto per le oasi, ma solo per i transiti, per i “fast mood”. Fino a quando? – sarebbe il caso di chiedersi. Eppure la tesi del “mordi e fuggi” è la più frequente, accettata e stabilizzata, quella che di solito prelude a una laudatio temporis acti. Nostalgia dei tempi in cui la piazza era un vero condensatore sociale, luogo abitato, di aggregazione vivace e chiassosa.
Questo progetto realizzato ad Aquino ha però chiuso lo spazio, ha imbrigliato ogni potenzialità dei rapporti tra le parti architettoniche poiché le scelte derivanti dalle diverse quote altimetriche hanno penalizzato ogni possibile sviluppo. Potremmo dire che le emergenze, i vuoti, e i muraglioni secchi e aspri degli edifici circostanti sono stati cuciti da una semplificativa muraglia raccordatrice senza impegno concettuale, ma come frutto di uno sbrigativo segno.
Nel nostro caso specifico questo “luogo negato” sembra piegato ad una concettualità dominata da un vetusto razionalismo revisionista figlio di una mano influenzata apparentemente da eredità alla Rossi o alla Portoghesi. Qui “la ragione arriva a vedere solo ciò che essa stessa produce secondo il suo progetto” o allo schizzo, al disegno che, appunto, soltanto per approssimazione corrisponde alla realtà.
Il processo deriva da un unico atto, da quella che Baudrillard (1981, p. 10), chiama la “precessione del simulacro”, e che propriamente consiste nell’anteporre alla realtà l’immagine cartografica, il disegno topografico, e pretendere che la prima discenda dalla seconda, in base a quel che potrebbe chiamarsi – mutuando l’espressione dalla critica cervantina – “il principio di realtà sufficiente” (Torrente Ballester 1975; Castilla del Pino 2005, pp.116-117).
Se si fosse lavorato alla luce di una semiotica dello spazio sulle forme di localizzazione, d’orientamento e di distribuzione, d’inclusionee d’esclusione, d’intersezione e di sovrapposizione, queste avrebbero restituito una misura alla prossimità e alla distanza, all’ampiezza e alla densità dei fatti e dei gesti umani.
Di conseguenza la questione che si pone oggi è quella di comprendere come si distingue l’oggetto composto dall’oggetto giustapposto. Come l’uno si libera del multiplo? Come un oggetto si chiude su se stesso, per disfarsi dell’altro? Qual è la grammatica degli oggetti? Come fa un oggetto giustapposto a diventare componente di un altro? Queste questioni entrano a pieno titolo in una semiotica dello spazio. La mia opinione è che invece l’intero impianto planimetrico e volumetrico avrebbe dovuto parlare “netto e chiaro”, col rigore dell’abaco, con la categoricità della partita doppia.
Ai luoghi del collettivo urbano, agli spazi di incontro si chiede una maggiore qualità, un maggior livello di attrattività. La recente fortuna di concetti come l’urban vitality nel mondo anglosassone o l’urbanità di scuola francese mettono in evidenza la necessità di costruire il progetto urbano partendo da un livello di densità delle città che favorisca la qualità sfatando la profezia wrightiana di suburbanizzazione.
Lo spazio pubblico dovrebbe essere legato al connettivo e alle porositàurbane:il progetto si doveva articolare partendo da chiari concetti di accessibilità – evoluzione del concetto di mobilità – e permeabilità – che si riferisce alla connessione tra un vuoto e l’altro anche attraverso reti più deboli.
In questo quadro il paesaggio non sarebbe divenuto puro sfondo della città compatta, nétantomenopiano indifferenziato su cui poggiare architetture più o meno efficienti. La piazza è indiscutibilmente lo spazio della memoria sociale nei termini di una relazione contrattuale o conflittuale con l’altro, istituzionalizzazione ed interpretazione, in chiave politica delle funzioni di mercato.
Rendere tale relazione una risorsa – ecco il fine della piazza. Porre l’interazione a fondamento degli assetti urbani, rivitalizzarla, pensarla come piano del contenuto di planimetrie che possano favorirla, rafforzando la componente civica. Anche nelle piazze d’Europa più recenti o sorte in periodi lontani dall’agoràe dal Foro – nel XII secolo con i Comuni ad esempio, è il caso dell’Italia – il tratto distintivo da difendere, o da creare ex novo, resta quello della democrazia.

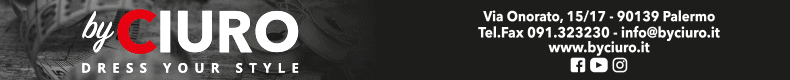

)












Un commento a “La piazza di Aquino chiusa da muraglioni: così è naufragata l’idea di democrazia”
Comments are closed.